
IL PENSIERO DEL DIRETTORE
Su Netflix ma anche su YouTube c’è un documentario che spiega, se non tutto, molto di quanto sta accadendo sulla barricata della resistenza ucraina all’invasione russa. S’intitola Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom. Racconta la battaglia della piazza Maidan (che poi vuole dire proprio “piazza”), quando nel 2014 giovani e no ucraini sconfissero l’arroganza e la violenza della leadership di Kiev di allora, filorussa, iper-corrotta, non europeista e molto agguerrita tra manganelli e strumenti repressivi più raffinati.
Ora, sarebbe sbagliato e un po’ risibile dire che se Vladimir Putin avesse visto questo documentario fatto di voci e immagini, anche dure, molto dure, non avrebbe sottovalutato, com’è invece accaduto, la resistenza ucraina, ma certamente avrebbe colto alcuni dati di fatto che oggi, sotto le bombe in terra di Kiev, non deperiscono, non ammainano bandiera. Soprattutto non si ammainano facilmente le bandiere giallo-blu della nazione che ha voluto e vuole liberarsi di un passato russocentrico e di tentazioni presenti russocratiche. Che poi giallo e blu sono anche i due colori dell’altra bandiera che almeno da allora gli ucraini non vogliono ammainare, quella dell’Unione europea. Ecco, anche qui, sarebbe sbagliato dire che l’Europa nasce più nella piazza gremitissima ed euroentusiasta di Kiev ritratta dal documentario, come nelle vie dei giovani volontari della resistenza ucraina raccontate sui social in queste drammatiche ore, perché almeno da Ventotene in poi la scalcagnata, a volte antipatica e spesso distratta Europa comunque di strada ne ha fatta, e si è allargata, e si è rafforzata, e ha affrontato anche una pandemia globale. E oggi le voci antieuropee nelle terre d’Europa si sono lentamente affievolite grazie all’evidenza clamorosa dell’importanza di affrontare problemi globali all’interno di alleanze che possono competere e cooperare a livello globale.
Detto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni sono che quando un popolo crede in qualcosa di solito viene sottovalutato da chi non crede in nulla (o quasi). In Winter on fire si vede un popolo, sfaccettato, complesso, colto, profondo, ma sicuramente convinto di voler vivere in pace, in libertà, in democrazia, in Europa. E scusatemi se è poco. La forza delle idee, spesso perfino di una sola idea, non può essere costruita a tavolino, sceneggiata, artefatta: quando c’è, questa forza, si svolge facilmente in narrazione con spontanea naturalezza, quella spontanea naturalezza che ti fa superare la paura, che ti dona un po’ di incoscienza, quell’incoscienza che i leader devono sempre gestire, ma che i popoli non possono che sublimare in tenacia e audacia.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 L’insonnia è un mondo a parte, anche se basta googolare per scoprire che ne soffrono – c’è chi dice – anche 12 milioni di italiani. L’insonnia è un mondo a parte perché quando uno è insonne non può, anche volendolo, creare un mondo con tutti gli altri che ovunque nel pianeta Terra non dormono e nello stesso momento. C’è poi il derby con sbadigli tra gli insonni che non si addormentano e gli insonni che invece si svegliano più e più volte, o magari non si addormentano più, dopo lo spuntino al frigo. Gli insonni sono una categoria non protetta anche perché sono fuori dalla fascia protetta della televisione. E non esistono prodotti per gli insonni, a parte quelli chimici, cioè i farmaci, la radio, i social network con account di persone che vivono in altri fusi orari e appunto la tv, che però li (ci) tratta o come raffinatissimi intellettuali pronti a guardare soltanto film cinesi sottotitolati in tedesco o iraniani sottotitolati in francese oppure come sfrenati consumisti appassionati di televendite e di aspirapolvere a vapore per divani. Vedete che non siamo protetti, noi comuni insonni.
L’insonnia è un mondo a parte, anche se basta googolare per scoprire che ne soffrono – c’è chi dice – anche 12 milioni di italiani. L’insonnia è un mondo a parte perché quando uno è insonne non può, anche volendolo, creare un mondo con tutti gli altri che ovunque nel pianeta Terra non dormono e nello stesso momento. C’è poi il derby con sbadigli tra gli insonni che non si addormentano e gli insonni che invece si svegliano più e più volte, o magari non si addormentano più, dopo lo spuntino al frigo. Gli insonni sono una categoria non protetta anche perché sono fuori dalla fascia protetta della televisione. E non esistono prodotti per gli insonni, a parte quelli chimici, cioè i farmaci, la radio, i social network con account di persone che vivono in altri fusi orari e appunto la tv, che però li (ci) tratta o come raffinatissimi intellettuali pronti a guardare soltanto film cinesi sottotitolati in tedesco o iraniani sottotitolati in francese oppure come sfrenati consumisti appassionati di televendite e di aspirapolvere a vapore per divani. Vedete che non siamo protetti, noi comuni insonni.
Ognuno poi ha il suo rimedio della nonna; io, per esempio, all’Università avevo Radio radicale come soluzione: so ancora a memoria più frasi da comizio di Marco Pannella che articoli del codice civile allora sulla mia scrivania. Certo, poi l’insonnia ha anche più di un che di letterario. Ci immaginiamo tutti i grandi scrittori più recenti, da Philip Roth a Michel Houellebecq, a scrivere perché non dormono e a non dormire per scrivere, quando magari si alzano, si sbarbano e si mettono a digitare sul pc in orario d’ufficio e vestiti come il dì di festa. Beh, nel caso di Houellebecq magari quest’ultima cosa è un po’ improbabile.
Dice che la pandemia ha fatto ovviamente male anche ai nostri sonni, e figuriamoci se no, e figuriamoci la guerra. L’insonnia infatti è la nostra seconda realtà, il nostro Metaverso poco ludico e molto solitario, è la nostra seconda vita, poco lucida e fatta di preoccupazioni, di angosce, dalla lite con il o la partner alla vita dei figli, fino a “mi sono ricordato di pagare il bollo della macchina?”. L’insonnia però è anche – come direbbe Claudio Bisio – il nostro scampolo di assenza, di libertà, perché l’insonnia si prende prepotentemente il suo tempo, anche se non è un blocchetto con tanto di descrizione nel calendario del nostro Outlook o nei foglietti sdruciti dell’agendina. Ho sempre pensato che sarebbe bello raccontare, magari in uno di quei podcast che ora vanno tanto di moda, tutto quello che è stato creato di notte, dagli insonni, tutte le cose belle che non avremmo avuto se tutti dormissimo come dei ghiri. Ci vorrebbe un’idea. Una di queste notti stavo per iniziare a metterla in pratica, poi è suonata la sveglia della realtà assonnata. Alla prossima.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 C’è poco di così pieno come un silenzio, come ci sono tante cose vuote come molte parole. Serena Minazzi mi aveva appena mostrato la copertina di questa edizione di Oltre e io riflettevo, tra me e me: «Certo, che edizione difficile, esce in un periodo che ci riporta ai giorni più bui della nostra storia, oltre ogni immaginazione…». Poco dopo queste riflessioni tra il professionale e il personale, una cara amica, Ema, una procacciatrice di pensieri e riflessioni notturne, mi mandava il link a una pagina web con parole densissime di Chandra Livia Candiani: «Bisogna tacere come fanno i lupi». È il verso di una poesia. Ma che cosa significa «tacere come fanno i lupi»? Chiede giustamente Elisabetta Bucciarelli, nella conversazione per BookBlister (Pillole di libri e altre storie). «Immagina il silenzio di un lupo. È il silenzio di chi è sottotiro. Il silenzio della tensione verso la riflessione non pensata ma avvertita, come possibile equilibrio nell’azione, come varco. Quando più niente può essere detto, perché tutto è già stato detto e frainteso, c’è il silenzio che precede l’azione intonata a salvarci», dice Chandra Livia Candiani. E aggiunge: «La guerra mi ha ammutolita. Sembra così non contemporanea». Ecco, il silenzio pure, sembra così non contemporaneo. Eppure il contemporaneo ama il pieno, l’immaginazione, la creazione continua. Eppure che cosa meglio del silenzio, di un silenzio da lupi, può favorire il riempimento, la fantasia, la creatività. Il silenzio è l’attimo prima del tutto, forse anche l’attimo dopo. Quindi dobbiamo sperarlo, cercarlo, amarlo. “Che in principio era il Verbo” non va scomodato. “Che un bel tacer non fu mai stato scritto” non va banalizzato né attribuito come citazione perché semplicemente non si sa. Ecco, del silenzio non si sa nulla, ma allo stesso tempo lo conosciamo benissimo: il silenzio di quando non ci parliamo per rabbia, di quando non proferiamo parola per tristezza o angoscia, di quando è perché stiamo ascoltando, di quando è che ci stiamo riposando, di quando sappiamo che sta per scoppiare un pianto o una risata, di quando abbiamo paura, di quando cerchiamo di sentire ciò che non è facile sentire.
C’è poco di così pieno come un silenzio, come ci sono tante cose vuote come molte parole. Serena Minazzi mi aveva appena mostrato la copertina di questa edizione di Oltre e io riflettevo, tra me e me: «Certo, che edizione difficile, esce in un periodo che ci riporta ai giorni più bui della nostra storia, oltre ogni immaginazione…». Poco dopo queste riflessioni tra il professionale e il personale, una cara amica, Ema, una procacciatrice di pensieri e riflessioni notturne, mi mandava il link a una pagina web con parole densissime di Chandra Livia Candiani: «Bisogna tacere come fanno i lupi». È il verso di una poesia. Ma che cosa significa «tacere come fanno i lupi»? Chiede giustamente Elisabetta Bucciarelli, nella conversazione per BookBlister (Pillole di libri e altre storie). «Immagina il silenzio di un lupo. È il silenzio di chi è sottotiro. Il silenzio della tensione verso la riflessione non pensata ma avvertita, come possibile equilibrio nell’azione, come varco. Quando più niente può essere detto, perché tutto è già stato detto e frainteso, c’è il silenzio che precede l’azione intonata a salvarci», dice Chandra Livia Candiani. E aggiunge: «La guerra mi ha ammutolita. Sembra così non contemporanea». Ecco, il silenzio pure, sembra così non contemporaneo. Eppure il contemporaneo ama il pieno, l’immaginazione, la creazione continua. Eppure che cosa meglio del silenzio, di un silenzio da lupi, può favorire il riempimento, la fantasia, la creatività. Il silenzio è l’attimo prima del tutto, forse anche l’attimo dopo. Quindi dobbiamo sperarlo, cercarlo, amarlo. “Che in principio era il Verbo” non va scomodato. “Che un bel tacer non fu mai stato scritto” non va banalizzato né attribuito come citazione perché semplicemente non si sa. Ecco, del silenzio non si sa nulla, ma allo stesso tempo lo conosciamo benissimo: il silenzio di quando non ci parliamo per rabbia, di quando non proferiamo parola per tristezza o angoscia, di quando è perché stiamo ascoltando, di quando è che ci stiamo riposando, di quando sappiamo che sta per scoppiare un pianto o una risata, di quando abbiamo paura, di quando cerchiamo di sentire ciò che non è facile sentire.
Il silenzio è la nostra naturale predisposizione prima che qualunque sovrastruttura, lingua, sensazione senta la necessità di impossessarsi della nostra identità espressa dalle nostre parole. Il silenzio è la casa dei nostri pensieri più puri, più immoralisticamente sinceri e dunque etici. Il silenzio è tutto ciò che ci rimane quando abbiamo dimenticato tutto, quando ci siamo liberati di tutto, quando abbiamo soltanto voglia di noi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
Mi piacerebbe essere uno psicologo o uno psichiatra per avere un’idea di risposta a interrogativi che mi ronzano in mente assistendo ad alcuni fenomeni legati alle nuove tecnologie e ai media in generale. Per esempio, perché ci piace tanto guardare trasmissioni che riguardano cuochi o comunque persone che cucinano, come Masterchef e affini, anche se non possiamo assaggiare con il senso del gusto i loro piatti? Perché i nostri figli o i nostri nipoti amano guardare loro coetanei alle prese con l’ennesima sfida all’ennesimo videogioco, anche se loro non stanno giocando in prima persona? Perché invece di telefonare ora scriviamo o mandiamo audio, con la nostra voce dunque non in diretta ma registrata? Perché non ci stupisce più ascoltare la maestra dei nostri figli o dei nostri nipoti che ci dice: «Non si preoccupi se scrive male, se ha una brutta grafia, tanto a mano da grande non scriverà mai…»? Perché lentamente ma inesorabilmente la lettura di un libro viene via via sostituita da qualcuno che ci legge un (audio)libro o da un podcast ad alto contenuto e spirito narrativo? Perché mentre tutto sta diventando virtuale, come nel Metaverso di Mark Zuckerberg, la (seconda) realtà virtuale al posto del mondo reale, tutto sta anche diventando a portata di touch, di tocco delle dita, dal telefonino al self service al benzinaio? Perché, però, anche se usiamo le mani per comunicare via computer e via smartphone, la voce intanto sta per riconquistare uno spazio quando chiediamo ad Alexa o affini di contare dieci minuti per la cottura della pasta o di mettere su Radio Radicale?
Il sottofondo di risposta che mi veniva in mente, mentre queste caotiche domande mi ronzavano in testa, era che in fondo i media in generale e le nuove tecnologie in particolare, soprattutto quelle legate alla rete Internet e alle app, stanno abolendo i cinque sensi, mentre provocano una sempre più spiccata disintermediazione e dunque spersonalizzazione delle nostre relazioni con i nostri simili e con la realtà circostante. In verità, però, mi rendo conto che questa è una risposta pigra e conservatrice, timorosa e preoccupata. Forse, per essere più ottimisti e fiduciosi nel futuro, è più corretto dire che stiamo vivendo un rimescolamento dei cinque sensi e uno sviluppo di un sesto senso figlio delle nuove funzioni affidate ai nostri tradizionali cinque sensi. Per questa ragione mi piacerebbe tanto essere uno psicologo o uno psichiatra per cercare di abbozzare una risposta su quale prospettiva potrà mai derivare da questa commistione ormai inevitabile tra i sensi, la realtà e la nostra sempre più attiva immaginazione. Cioè, che tipo di vita ci sarà e che tipo di persona nascerà dalla convivenza costante e creativa tra i cinque sensi e il 5G?

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 Chi ha dei gatti, non uno però, almeno due e meglio ancora tre o di più (in colonia la gattità emerge in un’evidenza impermeabile al bamboleggiamento umano), almeno una volta è stato trafitto dalla consapevolezza che a loro non interessa che noi li celebriamo, soprattutto in loro assenza e in modi a loro non servono, tipo le feste, i libri, le cose a forma di gatto. Succede piuttosto il contrario, cioè che se entrate a contatto con un gatto comincia un processo di trasformazione che a un certo punto della relazione vi sfuggirà di mano, e diventerete il gatto del vostro gatto. Non va dimenticato infatti che mentre il cane è convinto di essere un umano che sbava, per i gatti noi siamo gatti meno svegli e inspiegabilmente grossi. Così arriviamo al fatto che oggi è la Giornata del gatto e a Milano e Roma ha preso il via la rassegna La città dei gatti, che durerà fino al 13 marzo. Se vi interessa il programma, andate su lacittadeigatti.it. A loro certamente no. Però c’è un popolo che, in tutta la sua stranezza, sembra aver capito qualcosa dei gatti, sono i giapponesi. Lo diciamo qui perché il marcatore di questo filo rosso sta nella letteratura del Sol Levante, popolata di felini che fanno quello che vogliono e per qualche motivo le loro azioni convergono a proteggere le nostre anime.
Chi ha dei gatti, non uno però, almeno due e meglio ancora tre o di più (in colonia la gattità emerge in un’evidenza impermeabile al bamboleggiamento umano), almeno una volta è stato trafitto dalla consapevolezza che a loro non interessa che noi li celebriamo, soprattutto in loro assenza e in modi a loro non servono, tipo le feste, i libri, le cose a forma di gatto. Succede piuttosto il contrario, cioè che se entrate a contatto con un gatto comincia un processo di trasformazione che a un certo punto della relazione vi sfuggirà di mano, e diventerete il gatto del vostro gatto. Non va dimenticato infatti che mentre il cane è convinto di essere un umano che sbava, per i gatti noi siamo gatti meno svegli e inspiegabilmente grossi. Così arriviamo al fatto che oggi è la Giornata del gatto e a Milano e Roma ha preso il via la rassegna La città dei gatti, che durerà fino al 13 marzo. Se vi interessa il programma, andate su lacittadeigatti.it. A loro certamente no. Però c’è un popolo che, in tutta la sua stranezza, sembra aver capito qualcosa dei gatti, sono i giapponesi. Lo diciamo qui perché il marcatore di questo filo rosso sta nella letteratura del Sol Levante, popolata di felini che fanno quello che vogliono e per qualche motivo le loro azioni convergono a proteggere le nostre anime.
Ora, la tradizione giapponese brulica di minuscole divinità cui è affidata la custodia di qualcosa, quindi i gatti vi hanno trovato tane a non finire. Sono arrivati dalla Cina nel VI secolo dopo Cristo al seguito dei monaci buddisti, che li portarono con sé per tenere i topi lontani dai manoscritti, da questa migrazione è scaturita una quantità di storie e figure. Il primo gatto giapponese citato in un documento scritto, intorno all’anno Mille, è stato Myobu no Otodo, che significa “Prima dama da compagnia del palazzo”, era dell’imperatore Ichijo e aveva al suo servizio una corte di donne. I marinai ne tenevano in barca uno a tre colori perché aveva il potere di tenere legate alle onde e spingere in fondo le anime dei morti in mare. Si narra anche che quando Buddha morì, tutti gli animali lo piansero ma non il gatto, perché sapeva già che Buddha era immortale (secondo una seconda tradizione era perché non gli importava. Anche il gatto è divisivo). Oggi questa sensibilità è un eccellente prodotto da esportazione, e infatti gli scaffali italiani compaiono continuamente versioni italiane di best seller giapponesi. Ve ne citiamo un pugno: Lei e il suo gatto di Shinankai Makoto e Nakagawa Naruki quattro donne le ci vite vengono salvate dai gatti e La mia via con i gatti di Morishita Noriko, usciti entrambi in questi primi mesi dell’anno per Einaudi. E, a ritroso negli ultimi anni, Il gatto che voleva salvare i libri di Natsukawa Sosuke (Mondadori), Cronache di un gatto viaggiatore di Arikawa Hiro (Garzanti). Ce ne sono molti altri, ma non dimenticate i sei felini che agiscono in Kafka sulla spiaggia, di Murakami Haruki, e soprattutto procuratevi una delle innumerevoli edizioni di Io sono un gatto di Natsume Soseki. Era il 1905, e grazie al gatto senza nome protagonista del romanzo, osservatore zen della vita umana, la cultura giapponese ha messo la testa fuori dal medioevo. Ci ha messo 1300 anni, ma il gatto è un chirurgo che non ha mai fretta.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
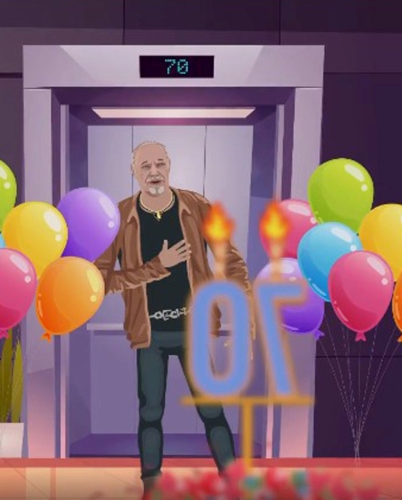 l fatto che Vasco Rossi abbia 70 anni è una cosa che non sta né in cielo e né in terra perché resterà il ragazzo di Zocca, punto, la più grande rockstar italiana di sempre. Che poi Gianni Morandi, che di anni ne ha perfino qualcuno in più, canti e balli e corra sul palco di Sanremo, come un giovanotto in divisa mandato a comprare il latte dalla mamma o a inginocchiarsi da te, non stupisce più nessuno. Anche perché di fianco a lui c’è un Jovanotti che pare un trentenne, e non è più, o un’Iva che canta l’eros o un’Orietta che duetta con Fedez e Lauro. Tralasciamo i Rolling Stones perché preferiamo i Beatles, anzi David Bowie, ma non possiamo non citare Ornella Muti che a fianco ad Amadeus al Festival o a Celentano in Innamorato pazzo non ha lasciato sul volto alcuna ruga di distinzione per farci indovinare quanto tempo è passato. Si potrebbe pensare che sia sempre il solito tema: non vogliamo invecchiare. Ma forse non è più (solo) così.
l fatto che Vasco Rossi abbia 70 anni è una cosa che non sta né in cielo e né in terra perché resterà il ragazzo di Zocca, punto, la più grande rockstar italiana di sempre. Che poi Gianni Morandi, che di anni ne ha perfino qualcuno in più, canti e balli e corra sul palco di Sanremo, come un giovanotto in divisa mandato a comprare il latte dalla mamma o a inginocchiarsi da te, non stupisce più nessuno. Anche perché di fianco a lui c’è un Jovanotti che pare un trentenne, e non è più, o un’Iva che canta l’eros o un’Orietta che duetta con Fedez e Lauro. Tralasciamo i Rolling Stones perché preferiamo i Beatles, anzi David Bowie, ma non possiamo non citare Ornella Muti che a fianco ad Amadeus al Festival o a Celentano in Innamorato pazzo non ha lasciato sul volto alcuna ruga di distinzione per farci indovinare quanto tempo è passato. Si potrebbe pensare che sia sempre il solito tema: non vogliamo invecchiare. Ma forse non è più (solo) così.
L’idea ora è quella di abolire le fasi, anche se la vita e la storia sono fatte di fasi. Ci disturba il processo evolutivo perché lo consideriamo quasi sempre involutivo. Sappiamo che l’elaborazione di un lutto, la fine e l’inizio di un amore o di un rapporto e la vita di una persona vivono di fasi, ma preferiamo fissare il presente in una fotografia, sempre la stessa, sul nostro profilo nei social network, un’immagine, a lungo la stessa, che ci ritrae in un momento e resta quella, anche se noi evolviamo, invecchiamo, tagliamo o perdiamo i capelli. Il problema profondo è che dell’evoluzione, dei cambi di fase, che pure sappiamo esistere, ci disturba l’impossibilità di controllarne i rapporti di causa ed effetto. Non sappiamo se nella fase successiva alla presente saremo o no felici, avremo o no successo, piaceremo o no al mondo e a noi stessi. E questo è l’aspetto critico del nostro inconfessabile ma ostentato desiderio di abolire o di disconoscere le fasi dell’esistenza.
Per gli artisti, però, ma non soltanto per loro, c’è anche un’idea positiva al fondo del desiderio di abolire le fasi, c’è la ricerca dell’assoluto, di qualcosa che ci sia per sempre e immutabile, e per chi crede la risposta è chiara. Per chi non crede la risposta è nella ricerca del classico, declinazione laica e culturale dell’assoluto. Il Partenone è per sempre, anche se non era così com’è ora. Albachiara è per sempre, anche se è del 1979. I Promessi sposi sono per sempre, anche se si lasciano. Gianni Morandi corre per sempre, anche se è un signore di una certa età. Se il cambio di fase disconosciuto e/o negato non produce stonature o ridicolo, ma anzi sentimenti e sensazioni positive, sei diventato un classico. Altrimenti no.
Non vale soltanto per l’arte. Sei persona per sempre, anche se la tua vita è fatta a fasi. E padre. E madre. E perbene. Insomma il bene è un classico, il resto no. Per fortuna.


 L’insonnia è un mondo a parte, anche se basta googolare per scoprire che ne soffrono – c’è chi dice – anche 12 milioni di italiani. L’insonnia è un mondo a parte perché quando uno è insonne non può, anche volendolo, creare un mondo con tutti gli altri che ovunque nel pianeta Terra non dormono e nello stesso momento. C’è poi il derby con sbadigli tra gli insonni che non si addormentano e gli insonni che invece si svegliano più e più volte, o magari non si addormentano più, dopo lo spuntino al frigo. Gli insonni sono una categoria non protetta anche perché sono fuori dalla fascia protetta della televisione. E non esistono prodotti per gli insonni, a parte quelli chimici, cioè i farmaci, la radio, i social network con account di persone che vivono in altri fusi orari e appunto la tv, che però li (ci) tratta o come raffinatissimi intellettuali pronti a guardare soltanto film cinesi sottotitolati in tedesco o iraniani sottotitolati in francese oppure come sfrenati consumisti appassionati di televendite e di aspirapolvere a vapore per divani. Vedete che non siamo protetti, noi comuni insonni.
L’insonnia è un mondo a parte, anche se basta googolare per scoprire che ne soffrono – c’è chi dice – anche 12 milioni di italiani. L’insonnia è un mondo a parte perché quando uno è insonne non può, anche volendolo, creare un mondo con tutti gli altri che ovunque nel pianeta Terra non dormono e nello stesso momento. C’è poi il derby con sbadigli tra gli insonni che non si addormentano e gli insonni che invece si svegliano più e più volte, o magari non si addormentano più, dopo lo spuntino al frigo. Gli insonni sono una categoria non protetta anche perché sono fuori dalla fascia protetta della televisione. E non esistono prodotti per gli insonni, a parte quelli chimici, cioè i farmaci, la radio, i social network con account di persone che vivono in altri fusi orari e appunto la tv, che però li (ci) tratta o come raffinatissimi intellettuali pronti a guardare soltanto film cinesi sottotitolati in tedesco o iraniani sottotitolati in francese oppure come sfrenati consumisti appassionati di televendite e di aspirapolvere a vapore per divani. Vedete che non siamo protetti, noi comuni insonni. C’è poco di così pieno come un silenzio, come ci sono tante cose vuote come molte parole. Serena Minazzi mi aveva appena mostrato la copertina di questa edizione di Oltre e io riflettevo, tra me e me: «Certo, che edizione difficile, esce in un periodo che ci riporta ai giorni più bui della nostra storia, oltre ogni immaginazione…». Poco dopo queste riflessioni tra il professionale e il personale, una cara amica, Ema, una procacciatrice di pensieri e riflessioni notturne, mi mandava il link a una pagina web con parole densissime di Chandra Livia Candiani: «Bisogna tacere come fanno i lupi». È il verso di una poesia. Ma che cosa significa «tacere come fanno i lupi»? Chiede giustamente Elisabetta Bucciarelli, nella conversazione per BookBlister (Pillole di libri e altre storie). «Immagina il silenzio di un lupo. È il silenzio di chi è sottotiro. Il silenzio della tensione verso la riflessione non pensata ma avvertita, come possibile equilibrio nell’azione, come varco. Quando più niente può essere detto, perché tutto è già stato detto e frainteso, c’è il silenzio che precede l’azione intonata a salvarci», dice Chandra Livia Candiani. E aggiunge: «La guerra mi ha ammutolita. Sembra così non contemporanea». Ecco, il silenzio pure, sembra così non contemporaneo. Eppure il contemporaneo ama il pieno, l’immaginazione, la creazione continua. Eppure che cosa meglio del silenzio, di un silenzio da lupi, può favorire il riempimento, la fantasia, la creatività. Il silenzio è l’attimo prima del tutto, forse anche l’attimo dopo. Quindi dobbiamo sperarlo, cercarlo, amarlo. “Che in principio era il Verbo” non va scomodato. “Che un bel tacer non fu mai stato scritto” non va banalizzato né attribuito come citazione perché semplicemente non si sa. Ecco, del silenzio non si sa nulla, ma allo stesso tempo lo conosciamo benissimo: il silenzio di quando non ci parliamo per rabbia, di quando non proferiamo parola per tristezza o angoscia, di quando è perché stiamo ascoltando, di quando è che ci stiamo riposando, di quando sappiamo che sta per scoppiare un pianto o una risata, di quando abbiamo paura, di quando cerchiamo di sentire ciò che non è facile sentire.
C’è poco di così pieno come un silenzio, come ci sono tante cose vuote come molte parole. Serena Minazzi mi aveva appena mostrato la copertina di questa edizione di Oltre e io riflettevo, tra me e me: «Certo, che edizione difficile, esce in un periodo che ci riporta ai giorni più bui della nostra storia, oltre ogni immaginazione…». Poco dopo queste riflessioni tra il professionale e il personale, una cara amica, Ema, una procacciatrice di pensieri e riflessioni notturne, mi mandava il link a una pagina web con parole densissime di Chandra Livia Candiani: «Bisogna tacere come fanno i lupi». È il verso di una poesia. Ma che cosa significa «tacere come fanno i lupi»? Chiede giustamente Elisabetta Bucciarelli, nella conversazione per BookBlister (Pillole di libri e altre storie). «Immagina il silenzio di un lupo. È il silenzio di chi è sottotiro. Il silenzio della tensione verso la riflessione non pensata ma avvertita, come possibile equilibrio nell’azione, come varco. Quando più niente può essere detto, perché tutto è già stato detto e frainteso, c’è il silenzio che precede l’azione intonata a salvarci», dice Chandra Livia Candiani. E aggiunge: «La guerra mi ha ammutolita. Sembra così non contemporanea». Ecco, il silenzio pure, sembra così non contemporaneo. Eppure il contemporaneo ama il pieno, l’immaginazione, la creazione continua. Eppure che cosa meglio del silenzio, di un silenzio da lupi, può favorire il riempimento, la fantasia, la creatività. Il silenzio è l’attimo prima del tutto, forse anche l’attimo dopo. Quindi dobbiamo sperarlo, cercarlo, amarlo. “Che in principio era il Verbo” non va scomodato. “Che un bel tacer non fu mai stato scritto” non va banalizzato né attribuito come citazione perché semplicemente non si sa. Ecco, del silenzio non si sa nulla, ma allo stesso tempo lo conosciamo benissimo: il silenzio di quando non ci parliamo per rabbia, di quando non proferiamo parola per tristezza o angoscia, di quando è perché stiamo ascoltando, di quando è che ci stiamo riposando, di quando sappiamo che sta per scoppiare un pianto o una risata, di quando abbiamo paura, di quando cerchiamo di sentire ciò che non è facile sentire. Chi ha dei gatti, non uno però, almeno due e meglio ancora tre o di più (in colonia la gattità emerge in un’evidenza impermeabile al bamboleggiamento umano), almeno una volta è stato trafitto dalla consapevolezza che a loro non interessa che noi li celebriamo, soprattutto in loro assenza e in modi a loro non servono, tipo le feste, i libri, le cose a forma di gatto. Succede piuttosto il contrario, cioè che se entrate a contatto con un gatto comincia un processo di trasformazione che a un certo punto della relazione vi sfuggirà di mano, e diventerete il gatto del vostro gatto. Non va dimenticato infatti che mentre il cane è convinto di essere un umano che sbava, per i gatti noi siamo gatti meno svegli e inspiegabilmente grossi. Così arriviamo al fatto che oggi è la Giornata del gatto e a Milano e Roma ha preso il via la rassegna La città dei gatti, che durerà fino al 13 marzo. Se vi interessa il programma, andate su lacittadeigatti.it. A loro certamente no. Però c’è un popolo che, in tutta la sua stranezza, sembra aver capito qualcosa dei gatti, sono i giapponesi. Lo diciamo qui perché il marcatore di questo filo rosso sta nella letteratura del Sol Levante, popolata di felini che fanno quello che vogliono e per qualche motivo le loro azioni convergono a proteggere le nostre anime.
Chi ha dei gatti, non uno però, almeno due e meglio ancora tre o di più (in colonia la gattità emerge in un’evidenza impermeabile al bamboleggiamento umano), almeno una volta è stato trafitto dalla consapevolezza che a loro non interessa che noi li celebriamo, soprattutto in loro assenza e in modi a loro non servono, tipo le feste, i libri, le cose a forma di gatto. Succede piuttosto il contrario, cioè che se entrate a contatto con un gatto comincia un processo di trasformazione che a un certo punto della relazione vi sfuggirà di mano, e diventerete il gatto del vostro gatto. Non va dimenticato infatti che mentre il cane è convinto di essere un umano che sbava, per i gatti noi siamo gatti meno svegli e inspiegabilmente grossi. Così arriviamo al fatto che oggi è la Giornata del gatto e a Milano e Roma ha preso il via la rassegna La città dei gatti, che durerà fino al 13 marzo. Se vi interessa il programma, andate su lacittadeigatti.it. A loro certamente no. Però c’è un popolo che, in tutta la sua stranezza, sembra aver capito qualcosa dei gatti, sono i giapponesi. Lo diciamo qui perché il marcatore di questo filo rosso sta nella letteratura del Sol Levante, popolata di felini che fanno quello che vogliono e per qualche motivo le loro azioni convergono a proteggere le nostre anime.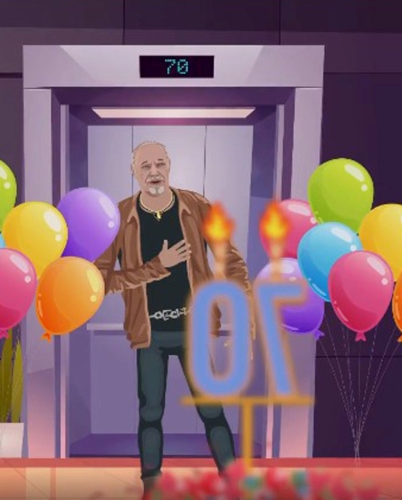 l fatto che Vasco Rossi abbia 70 anni è una cosa che non sta né in cielo e né in terra perché resterà il ragazzo di Zocca, punto, la più grande rockstar italiana di sempre. Che poi Gianni Morandi, che di anni ne ha perfino qualcuno in più, canti e balli e corra sul palco di Sanremo, come un giovanotto in divisa mandato a comprare il latte dalla mamma o a inginocchiarsi da te, non stupisce più nessuno. Anche perché di fianco a lui c’è un Jovanotti che pare un trentenne, e non è più, o un’Iva che canta l’eros o un’Orietta che duetta con Fedez e Lauro. Tralasciamo i Rolling Stones perché preferiamo i Beatles, anzi David Bowie, ma non possiamo non citare Ornella Muti che a fianco ad Amadeus al Festival o a Celentano in Innamorato pazzo non ha lasciato sul volto alcuna ruga di distinzione per farci indovinare quanto tempo è passato. Si potrebbe pensare che sia sempre il solito tema: non vogliamo invecchiare. Ma forse non è più (solo) così.
l fatto che Vasco Rossi abbia 70 anni è una cosa che non sta né in cielo e né in terra perché resterà il ragazzo di Zocca, punto, la più grande rockstar italiana di sempre. Che poi Gianni Morandi, che di anni ne ha perfino qualcuno in più, canti e balli e corra sul palco di Sanremo, come un giovanotto in divisa mandato a comprare il latte dalla mamma o a inginocchiarsi da te, non stupisce più nessuno. Anche perché di fianco a lui c’è un Jovanotti che pare un trentenne, e non è più, o un’Iva che canta l’eros o un’Orietta che duetta con Fedez e Lauro. Tralasciamo i Rolling Stones perché preferiamo i Beatles, anzi David Bowie, ma non possiamo non citare Ornella Muti che a fianco ad Amadeus al Festival o a Celentano in Innamorato pazzo non ha lasciato sul volto alcuna ruga di distinzione per farci indovinare quanto tempo è passato. Si potrebbe pensare che sia sempre il solito tema: non vogliamo invecchiare. Ma forse non è più (solo) così.







