
IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 La nostra vita è appesa agli aggettivi, mamma mia che condanna. E la constatazione è molto rassicurante dal punto di vista della comprensione delle cose, meno rassicurante dal punto di vista dell’oggettività del reale (e per fortuna). Perché, se il reale dipende da un aggettivo, chi lo sceglie lo definisce e dunque lo manipola, a suo modo. Il catalogo è questo.
La nostra vita è appesa agli aggettivi, mamma mia che condanna. E la constatazione è molto rassicurante dal punto di vista della comprensione delle cose, meno rassicurante dal punto di vista dell’oggettività del reale (e per fortuna). Perché, se il reale dipende da un aggettivo, chi lo sceglie lo definisce e dunque lo manipola, a suo modo. Il catalogo è questo.
La divina commedia e la commedia, quanto sono distanti? La comédie e la comédie humaine e la comédie française, quanto sono distanti? I media e i social media sono due realtà differenti, anche se simili. Un buon amico e un amico buono non sono la stessa persona. L’economia e la nuova economia, ve le ricordate? Il governo e il governo tecnico, questa è la vera alternanza. Vera, ah, ecco. Ora però l’economia è soprattutto sostenibile. Il fine e il lieto fine fanno cambiare perfino il senso al sostantivo, come figura e brutta figura. Se l’operazione militare è “speciale”, l’aggettivo serve a dire che non è guerra, perché insomma tra operazione militare e guerra questa grande differenza non si nota certo, se invece l’operazione è speciale, parliamone in russo… Dove tra aggettivo e verbo c’è di mezzo un mondo e uno slogan: la rivoluzione russa, la rivoluzione non russa. Un tempo poi però si parlava di guerra “giusta”, per svelenire guerra, e/o di attacco “preventivo”, per parafrasare difesa. A proposito, ve la ricordate la “difesa attiva”, quella dell’Italia quando si combatteva nei balcani? Se no, pensate allora alla Guerra fredda: che differenza abissale (che peraltro aggettivo è) da guerra e basta e “Guerra fredda”. Non ho mai capito invece perché l’atletica è leggera, come la musica. E sempre nel contesto della leggerrezza c’è il problema che un conto è dire “la leggerezza dell’essere”, ma sei matto?, e ben altro conto è titolare su “l’insostenibile” leggerezza dell’essere, mai sei un genio! L’amore poi si divede in tre aggettivi: il primo, il grande, l’infelice. Ah, sì, certo, ci sarebbe anche “l’eterno”. Però ci credono soprattutto quelli che credono alla “buona” novella. No, che dici, è un valore anche “laico”, anche dei cattolici “adulti”. La democrazia invece era cristiana, il partito comunista e il compromesso storico. La pandemia, del resto, è gravissima se è globale, come la scuola dev’essere buona e la giustizia giusta. La ricerca dell’aggettivo intonato è l’obiettivo di chiunque scriva, eliminarli del tutto, gli aggettivi, è il capolavoro di chiunque sappia scrivere. Soprattutto di chi sa scrivere per raccontare: “show, don’t tell”, mostralo e non dirlo, è la regola di chi sa scrivere perché l’aggettivo lo dica il lettore, non lo scrittore. Così fa anche il creatore o il destino: in principio infatti era il verbo, la ragione, semmai la parola, aggettivi e avverbi, siamo liberi, che bello!, mettiamoli noi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
La nostra vita è appesa agli aggettivi, mamma mia che condanna. E la constatazione è molto rassicurante dal punto di vista della comprensione delle cose, meno rassicurante dal punto di vista dell’oggettività del reale (e per fortuna). Perché, se il reale dipende da un aggettivo, chi lo sceglie lo definisce e dunque lo manipola, a suo modo. Il catalogo è questo.
La divina commedia e la commedia, quanto sono distanti? La comédie e la comédie humaine e la comédie française, quanto sono distanti? I media e i social media sono due realtà differenti, anche se simili. Un buon amico e un amico buono non sono la stessa persona. L’economia e la nuova economia, ve le ricordate? Il governo e il governo tecnico, questa è la vera alternanza. Vera, ah, ecco. Ora però l’economia è soprattutto sostenibile. Il fine e il lieto fine fanno cambiare perfino il senso al sostantivo, come figura e brutta figura. Se l’operazione militare è “speciale”, l’aggettivo serve a dire che non è guerra, perché insomma tra operazione militare e guerra questa grande differenza non si nota certo, se invece l’operazione è speciale, parliamone in russo… Dove tra aggettivo e verbo c’è di mezzo un mondo e uno slogan: la rivoluzione russa, la rivoluzione non russa. Un tempo poi però si parlava di guerra “giusta”, per svelenire guerra, e/o di attacco “preventivo”, per parafrasare difesa. A proposito, ve la ricordate la “difesa attiva”, quella dell’Italia quando si combatteva nei balcani? Se no, pensate allora alla Guerra fredda: che differenza abissale (che peraltro aggettivo è) da guerra e basta e “Guerra fredda”. Non ho mai capito invece perché l’atletica è leggera, come la musica. E sempre nel contesto della leggerrezza c’è il problema che un conto è dire “la leggerezza dell’essere”, ma sei matto?, e ben altro conto è titolare su “l’insostenibile” leggerezza dell’essere, mai sei un genio! L’amore poi si divede in tre aggettivi: il primo, il grande, l’infelice. Ah, sì, certo, ci sarebbe anche “l’eterno”. Però ci credono soprattutto quelli che credono alla “buona” novella. No, che dici, è un valore anche “laico”, anche dei cattolici “adulti”. La democrazia invece era cristiana, il partito comunista e il compromesso storico. La pandemia, del resto, è gravissima se è globale, come la scuola dev’essere buona e la giustizia giusta. La ricerca dell’aggettivo intonato è l’obiettivo di chiunque scriva, eliminarli del tutto, gli aggettivi, è il capolavoro di chiunque sappia scrivere. Soprattutto di chi sa scrivere per raccontare: “show, don’t tell”, mostralo e non dirlo, è la regola di chi sa scrivere perché l’aggettivo lo dica il lettore, non lo scrittore. Così fa anche il creatore o il destino: in principio infatti era il verbo, la ragione, semmai la parola, aggettivi e avverbi, siamo liberi, che bello!, mettiamoli noi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
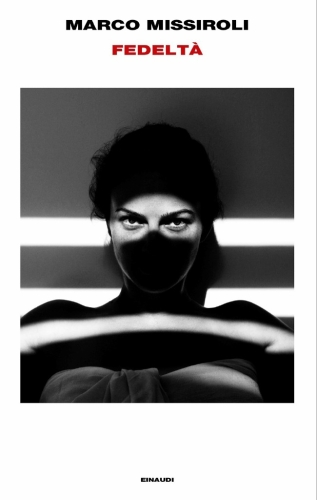 Perché si scrive un libro? Diciamo un romanzo, una biografia, un’autobiografia, tralasciando i saggi. Vanità? D’accordo, ma quello vale per tutto, le cose migliori le facciamo per vanità, non c’è nulla di male ad ammetterlo. Ci piace vantarci – come dice il maestro Maurizio Milani – quanto meno con noi stessi. Però ci dev’essere dell’altro. Raccontare una storia, ovvio e bellissimo. Si scrive un libro per abbracciare definitivamente qualcosa o qualcuno, come per non liberarsene mai, o per la lasciare definitivamente andare qualcosa o qualcuno, come per liberarsene per sempre. Il problema è che poi spesso queste due opposte esigenze si fondono e si mescolano, dunque tu scrivi un libro per liberarti di una cosa o una persona e crei una storia che in fondo resta per sempre, e viceversa. Mi è venuta in mente questa riflessione perché un amico ha appena scritto un libro, un romanzo noir, e un’amica ne sta scrivendo uno molto autobiografico e lo sta leggendo a un adolescente molto incuriosito. Ma, appunto, c’è dell’altro. Prendete Fedeltà del bravissimo scrittore Marco Missiroli.
Perché si scrive un libro? Diciamo un romanzo, una biografia, un’autobiografia, tralasciando i saggi. Vanità? D’accordo, ma quello vale per tutto, le cose migliori le facciamo per vanità, non c’è nulla di male ad ammetterlo. Ci piace vantarci – come dice il maestro Maurizio Milani – quanto meno con noi stessi. Però ci dev’essere dell’altro. Raccontare una storia, ovvio e bellissimo. Si scrive un libro per abbracciare definitivamente qualcosa o qualcuno, come per non liberarsene mai, o per la lasciare definitivamente andare qualcosa o qualcuno, come per liberarsene per sempre. Il problema è che poi spesso queste due opposte esigenze si fondono e si mescolano, dunque tu scrivi un libro per liberarti di una cosa o una persona e crei una storia che in fondo resta per sempre, e viceversa. Mi è venuta in mente questa riflessione perché un amico ha appena scritto un libro, un romanzo noir, e un’amica ne sta scrivendo uno molto autobiografico e lo sta leggendo a un adolescente molto incuriosito. Ma, appunto, c’è dell’altro. Prendete Fedeltà del bravissimo scrittore Marco Missiroli.
È un romanzo dolce e sontuoso, fatto di vite normali ma di vite, di personaggi normali ma di persone. Ed è diventato una serie televisiva omonima su Netflix. Però, senza voler spoilerare nulla, la serie televisiva è un’evoluzione del libro che per me dice tutto sulla differenza tra letteratura e cinema. Perché nella serie televisiva le vite diventano (più) estreme, i look più marcati, i personaggi più personaggi e meno persone. Quindi forse scriviamo un libro per far diventare normale, cioè una storia, tutto ciò che ci sembra estremo, televisivo e/o cinematografico, mentre lo viviamo. Questa elucubrazione intellettualoide, questa super cazzola, direbbe il conte Mascetti, cioè il maestro Ugo Tognazzi (a proposito, tanti auguri per i cento anni festeggiati lassù e ricordati quaggiù dal bel documentario La voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi presentato al BAff alcuni giorni fa), forse serve almeno in parte per capire i destinatari – in commercialese si potrebbe dire “i target” – di un libro rispetto a una serie televisiva, o la predisposizione che abbiamo quando leggiamo un libro, come Fedeltà, e cioè voglia di riflessione, di introspezione e di normalizzazione pensosa, o quando guardiamo una serie televisiva, come Fedeltà, e cioè voglia di svago, di emozione e di radicalizzazione divertita. Insomma, siamo sempre noi alle prese con i nostri opposti interiori e con la voglia di lasciare andare tutto e di non lasciare andare mai nulla, di essere noi stessi l’attimo prima e l’attimo dopo dei nostri istinti magnetici, dei nostri poli opposti. È la nostra matta e saggia fedeltà a noi stessi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 Il consenso crea consenso che crea consenso. È così che funzionano il marketing digitale, gli algoritmi dei motori di ricerca su Internet, le nostre scelte, le nostre vite. Per esempio, entrereste mai in un locale vuoto situato proprio in mezzo a due locali pieni? O scegliereste uno dei due esercizi affollati? Immaginate. Sabato sera. Cerchi su una delle applicazioni per trovare all’improvviso e scegliere con qualche cognizione di causa un ristorante, un aperitivo, un’enoteca. Ti viene proposta un’enoteca con voto di altissimo gradimento e un certo numero di recensioni lusinghiere, molto. Ecco, vedi, il ueb sa che preferisci il vino alla birra. Alcune di queste recensioni dicono esattamente che lì troverai proprio quello che tu cerchi. Anzi, quel posto è lì che da sempre aspetta te per una serata cameo. Verifichi che non siano tutte anonime o pseudonime, le recensioni: amici degli amici del gestore? Chiami per sapere se c’è posto, «sì, certo», rispondono. Arrivi davanti al locale prescelto. Sarà pure lì per un cameo, però è ferocemente vuoto e un annoiato signore consulta scoraggiato il suo smartphone.
Il consenso crea consenso che crea consenso. È così che funzionano il marketing digitale, gli algoritmi dei motori di ricerca su Internet, le nostre scelte, le nostre vite. Per esempio, entrereste mai in un locale vuoto situato proprio in mezzo a due locali pieni? O scegliereste uno dei due esercizi affollati? Immaginate. Sabato sera. Cerchi su una delle applicazioni per trovare all’improvviso e scegliere con qualche cognizione di causa un ristorante, un aperitivo, un’enoteca. Ti viene proposta un’enoteca con voto di altissimo gradimento e un certo numero di recensioni lusinghiere, molto. Ecco, vedi, il ueb sa che preferisci il vino alla birra. Alcune di queste recensioni dicono esattamente che lì troverai proprio quello che tu cerchi. Anzi, quel posto è lì che da sempre aspetta te per una serata cameo. Verifichi che non siano tutte anonime o pseudonime, le recensioni: amici degli amici del gestore? Chiami per sapere se c’è posto, «sì, certo», rispondono. Arrivi davanti al locale prescelto. Sarà pure lì per un cameo, però è ferocemente vuoto e un annoiato signore consulta scoraggiato il suo smartphone.
wÈ completamente vuoto, capisci. Dai un occhio a sinistra: c’è un’osteria mezza piena, con viavai di famiglie e green pass. Dai un occhio a destra: c’è una birreria nordica con viavai di ragazzoni e giubbotti di pelle, uno di quei pub perfetti per un gruppo di amici e per vedere la partita. Anche qui c’è gente. Due locali mezzi pieni e in mezzo, il vaso di coccio, un locale perfettamente vuoto. Entrate anche se avete chiamato? Dai, il senso di colpa prevale, in fondo il povero gestore ha risposto «sì, certo, c’è posto, pure troppo…». Insomma, dai dai, volevate l’enoteca, odiate la birra e non è per una cena di famiglia che siete lì. Eppure l’imbarazzo di solcare l’ingresso di un locale vuoto concede la vittoria alla tentazione dell’osteria. «Ha prenotato?». «Sì, ma nel locale vuoto a fianco», sopprimi questa frase e dici: «No…». «Mi dispiace, non abbiamo posto, ma l’enoteca a fianco ha posto, pure troppo…». L’ultima cosa non l’ha detta, ecco, ma perché è vuota? Ma allora le recensioni? E il voto alto? Il consenso crea consenso che crea consenso. Passi davanti all’enoteca: «Ammazza, ma è proprio vuota. Ma come mai?», dici tra te e te. E vai a dare un occhio alla birreria nordica. Buia, maschia, odorosa di fritto che di più non si può. Entri. «Una piccola chiara…». «Non abbiamo piccole, solo…». Pochi secondi e odori già come se avessi fatto il bagno nell’olio esausto di un hamburgeria, ma di questo non avevi letto nulla nelle recensioni. Vorresti andare a salutare il gestore dell’enoteca, ma sarebbe un peccato interrompere la sua navigazione solitaria via smartphone con tutto quel fritto. Auto, via.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 Sulle questioni esistenziali, quelle che toccano il senso della vita, non esistono domande semplici, esistono soltanto domande di cui abbiamo trovato, o comunque conosciamo, la risposta. Ora, provate a dare una risposta a questa semplice domanda: come si diventa felici? Ecco, da questo interrogativo familiare, posto da una figlia, parte il viaggio di Alessandro Cattelan su Netflix, una trasmissione in più puntate e più interviste e più trovate spettacolari, fino al culmine assoluto di un conduttore di X Factor che partecipa a un altro X Factor come cantante. È certamente molto ambizioso, come progetto, certamente molto originale, nella sua straordinaria banalità: perché chi non si chiede ogni giorno che cosa sia la felicità? E soprattutto chi non cerca risposte da amici, conoscenti saggi, guide spirituali, psicoanalisti e perfino social media o motori di ricerca?
Sulle questioni esistenziali, quelle che toccano il senso della vita, non esistono domande semplici, esistono soltanto domande di cui abbiamo trovato, o comunque conosciamo, la risposta. Ora, provate a dare una risposta a questa semplice domanda: come si diventa felici? Ecco, da questo interrogativo familiare, posto da una figlia, parte il viaggio di Alessandro Cattelan su Netflix, una trasmissione in più puntate e più interviste e più trovate spettacolari, fino al culmine assoluto di un conduttore di X Factor che partecipa a un altro X Factor come cantante. È certamente molto ambizioso, come progetto, certamente molto originale, nella sua straordinaria banalità: perché chi non si chiede ogni giorno che cosa sia la felicità? E soprattutto chi non cerca risposte da amici, conoscenti saggi, guide spirituali, psicoanalisti e perfino social media o motori di ricerca?
Il bello del viaggio, che peraltro già potrebbe essere una risposta alla suddetta domanda, sta nella scelta degli interlocutori, un bianchissimo e limpido Roberto Baggio, un dolcissimo e saggio, Gianluca Vialli, gente che si vuole sposare, gente che (non) vuole lanciarsi da un ponte imbragata a un elastico, persone credenti di vari credo, un amico del protagonista, attore e comico, Francesco Mandelli, un per nulla disunito premio Oscar, come Paolo Sorrentino, Elio che è Elio delle storie tese, e altri ancora. Ecco, in questi “altri ancora” ci sono i due veri guru, i due veri super cuochi nella cucina della nostra contentezza. Qui non si spoilera, qui si conversa, dunque lasciamo la sorpresa. Conversiamo però a proposito del fatto che spesso cerchiamo la felicità nelle cose da fare e forse potremmo invece iniziare dalle cose da non fare. Anche se il gioco narrativo scelto da Cattelan è l’opposto e in questo senso è riuscito. Cattelan, infatti, risulta credibile, nella sua ricerca della felicità, non soltanto perché è un conduttore fresco e spontaneo, ma perché sembra sinceramente togliere dal cassetto dei suoi sogni alcuni piccoli desideri realizzati in questa serie di sedute psicoanalitiche molto ambulanti. E mentre tu sei lì che ti diverti, che ridi alle battute, tipo: «La felicità non è parlare con i cani. Anzi, un po’ sì, basta che non ti aspetti che ti rispondano…», arriva un volto stupendo che ha perfino il coraggio di spiegarti che è tutto sbagliato quello che abbiamo sempre pensato, non è affatto vero che la felicità sia una misteriosa miscela di congiunture astrali, talenti personali, destini fortunati, incroci benedetti di sguardi e di parole. Ma va, la felicità non è una cosa che assomiglia a qualcosa di artistico. È una cosa che assomiglia a qualcosa di matematico. Ne esiste, infatti, l’equazione. Eccola.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE
 Quella sottilissima, pessima sensazione che la guerra iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina da noi sia diventata, in meno di un mese, poco più di un argomento da talk show non mi abbandona. Eppure spero tanto sia una sensazione sbagliata. Il problema di fondo è che da tempo la politica nazionale è diventata una sorta di nuova telenovela costante e permanente che consente alle televisioni di creare personaggi e serie di trasmissioni a costi contenuti, con protagonisti predefiniti e giochi di ruoli scontati, ma pur sempre efficaci in termini di audience. Questa tendenza si abbevera del tema del momento, che in tempi ordinari è la polemica del giorno, magari soppesata bene grazie ai flussi di “mi piace” o “non mi piace” sui social media. In tempi straordinari, invece, questo fenomeno è accentuato dalla presenza di una trama prestabilita molto forte e capace di monopolizzare l’attenzione degli spettatori e dunque gli sforzi di autori e conduttori televisivi. Così è accaduto prima con il Covid e i virologi e i politici e i commentatori e poi adesso con la guerra e i generali e di nuovo i politici e gli analisti militari e di politica estera. Una delle concause di questo possibile slittamento dall’informazione all’infotainment, come si suole chiamare quel mix di informazione e di intrattenimento che riempie i nostri palinsesti, è la scarsa distinzione tra i notiziari, le trasmissioni di approfondimento e i talk show più o meno leggeri. Il tutto “aggravato” dalla difficoltà di affermazione presso il nostro pubblico delle reti all news, nonostante i pregevoli sforzi di approfondimento di SkyTg24, di copertura completa di RaiNews e di sensibilità ai temi politico-economici del Tgcom24.
Quella sottilissima, pessima sensazione che la guerra iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina da noi sia diventata, in meno di un mese, poco più di un argomento da talk show non mi abbandona. Eppure spero tanto sia una sensazione sbagliata. Il problema di fondo è che da tempo la politica nazionale è diventata una sorta di nuova telenovela costante e permanente che consente alle televisioni di creare personaggi e serie di trasmissioni a costi contenuti, con protagonisti predefiniti e giochi di ruoli scontati, ma pur sempre efficaci in termini di audience. Questa tendenza si abbevera del tema del momento, che in tempi ordinari è la polemica del giorno, magari soppesata bene grazie ai flussi di “mi piace” o “non mi piace” sui social media. In tempi straordinari, invece, questo fenomeno è accentuato dalla presenza di una trama prestabilita molto forte e capace di monopolizzare l’attenzione degli spettatori e dunque gli sforzi di autori e conduttori televisivi. Così è accaduto prima con il Covid e i virologi e i politici e i commentatori e poi adesso con la guerra e i generali e di nuovo i politici e gli analisti militari e di politica estera. Una delle concause di questo possibile slittamento dall’informazione all’infotainment, come si suole chiamare quel mix di informazione e di intrattenimento che riempie i nostri palinsesti, è la scarsa distinzione tra i notiziari, le trasmissioni di approfondimento e i talk show più o meno leggeri. Il tutto “aggravato” dalla difficoltà di affermazione presso il nostro pubblico delle reti all news, nonostante i pregevoli sforzi di approfondimento di SkyTg24, di copertura completa di RaiNews e di sensibilità ai temi politico-economici del Tgcom24.
In sostanza, quello che succede nella carta stampata, ovvero la non distinzione tra informazione da tabloid e giornali generalisti autorevoli, con la commistione di temi gravi e leggeri sulle pagine dello stesso foglio, accade sempre più spesso anche nell’informazione televisiva. Tutto ciò provoca una preoccupante sensazione di naturale equiparazione tra i temi, dove un argomento vale l’altro, se permette comunque di schierare in campo i “soliti” protagonisti, a costi di produzione per l’appunto contenuti e con moderati sforzi di creatività. Così facendo però è ovvio che debbano entrare in gioco logiche di ricerca degli ascolti che spingono alla sovraesposizione delle posizioni estreme – lo abbiamo visto con il Covid, lo vediamo con la guerra – a danno delle riflessioni più complesse, delle storie più difficili da raccontare e dei ragionamenti più soppesati.

 La nostra vita è appesa agli aggettivi, mamma mia che condanna. E la constatazione è molto rassicurante dal punto di vista della comprensione delle cose, meno rassicurante dal punto di vista dell’oggettività del reale (e per fortuna). Perché, se il reale dipende da un aggettivo, chi lo sceglie lo definisce e dunque lo manipola, a suo modo. Il catalogo è questo.
La nostra vita è appesa agli aggettivi, mamma mia che condanna. E la constatazione è molto rassicurante dal punto di vista della comprensione delle cose, meno rassicurante dal punto di vista dell’oggettività del reale (e per fortuna). Perché, se il reale dipende da un aggettivo, chi lo sceglie lo definisce e dunque lo manipola, a suo modo. Il catalogo è questo.
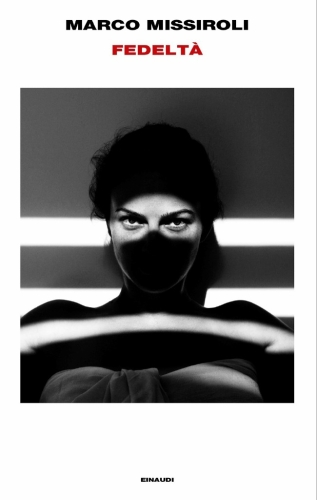 Perché si scrive un libro? Diciamo un romanzo, una biografia, un’autobiografia, tralasciando i saggi. Vanità? D’accordo, ma quello vale per tutto, le cose migliori le facciamo per vanità, non c’è nulla di male ad ammetterlo. Ci piace vantarci – come dice il maestro Maurizio Milani – quanto meno con noi stessi. Però ci dev’essere dell’altro. Raccontare una storia, ovvio e bellissimo. Si scrive un libro per abbracciare definitivamente qualcosa o qualcuno, come per non liberarsene mai, o per la lasciare definitivamente andare qualcosa o qualcuno, come per liberarsene per sempre. Il problema è che poi spesso queste due opposte esigenze si fondono e si mescolano, dunque tu scrivi un libro per liberarti di una cosa o una persona e crei una storia che in fondo resta per sempre, e viceversa. Mi è venuta in mente questa riflessione perché un amico ha appena scritto un libro, un romanzo noir, e un’amica ne sta scrivendo uno molto autobiografico e lo sta leggendo a un adolescente molto incuriosito. Ma, appunto, c’è dell’altro. Prendete Fedeltà del bravissimo scrittore Marco Missiroli.
Perché si scrive un libro? Diciamo un romanzo, una biografia, un’autobiografia, tralasciando i saggi. Vanità? D’accordo, ma quello vale per tutto, le cose migliori le facciamo per vanità, non c’è nulla di male ad ammetterlo. Ci piace vantarci – come dice il maestro Maurizio Milani – quanto meno con noi stessi. Però ci dev’essere dell’altro. Raccontare una storia, ovvio e bellissimo. Si scrive un libro per abbracciare definitivamente qualcosa o qualcuno, come per non liberarsene mai, o per la lasciare definitivamente andare qualcosa o qualcuno, come per liberarsene per sempre. Il problema è che poi spesso queste due opposte esigenze si fondono e si mescolano, dunque tu scrivi un libro per liberarti di una cosa o una persona e crei una storia che in fondo resta per sempre, e viceversa. Mi è venuta in mente questa riflessione perché un amico ha appena scritto un libro, un romanzo noir, e un’amica ne sta scrivendo uno molto autobiografico e lo sta leggendo a un adolescente molto incuriosito. Ma, appunto, c’è dell’altro. Prendete Fedeltà del bravissimo scrittore Marco Missiroli. Il consenso crea consenso che crea consenso. È così che funzionano il marketing digitale, gli algoritmi dei motori di ricerca su Internet, le nostre scelte, le nostre vite. Per esempio, entrereste mai in un locale vuoto situato proprio in mezzo a due locali pieni? O scegliereste uno dei due esercizi affollati? Immaginate. Sabato sera. Cerchi su una delle applicazioni per trovare all’improvviso e scegliere con qualche cognizione di causa un ristorante, un aperitivo, un’enoteca. Ti viene proposta un’enoteca con voto di altissimo gradimento e un certo numero di recensioni lusinghiere, molto. Ecco, vedi, il ueb sa che preferisci il vino alla birra. Alcune di queste recensioni dicono esattamente che lì troverai proprio quello che tu cerchi. Anzi, quel posto è lì che da sempre aspetta te per una serata cameo. Verifichi che non siano tutte anonime o pseudonime, le recensioni: amici degli amici del gestore? Chiami per sapere se c’è posto, «sì, certo», rispondono. Arrivi davanti al locale prescelto. Sarà pure lì per un cameo, però è ferocemente vuoto e un annoiato signore consulta scoraggiato il suo smartphone.
Il consenso crea consenso che crea consenso. È così che funzionano il marketing digitale, gli algoritmi dei motori di ricerca su Internet, le nostre scelte, le nostre vite. Per esempio, entrereste mai in un locale vuoto situato proprio in mezzo a due locali pieni? O scegliereste uno dei due esercizi affollati? Immaginate. Sabato sera. Cerchi su una delle applicazioni per trovare all’improvviso e scegliere con qualche cognizione di causa un ristorante, un aperitivo, un’enoteca. Ti viene proposta un’enoteca con voto di altissimo gradimento e un certo numero di recensioni lusinghiere, molto. Ecco, vedi, il ueb sa che preferisci il vino alla birra. Alcune di queste recensioni dicono esattamente che lì troverai proprio quello che tu cerchi. Anzi, quel posto è lì che da sempre aspetta te per una serata cameo. Verifichi che non siano tutte anonime o pseudonime, le recensioni: amici degli amici del gestore? Chiami per sapere se c’è posto, «sì, certo», rispondono. Arrivi davanti al locale prescelto. Sarà pure lì per un cameo, però è ferocemente vuoto e un annoiato signore consulta scoraggiato il suo smartphone. Sulle questioni esistenziali, quelle che toccano il senso della vita, non esistono domande semplici, esistono soltanto domande di cui abbiamo trovato, o comunque conosciamo, la risposta. Ora, provate a dare una risposta a questa semplice domanda: come si diventa felici? Ecco, da questo interrogativo familiare, posto da una figlia, parte il viaggio di Alessandro Cattelan su Netflix, una trasmissione in più puntate e più interviste e più trovate spettacolari, fino al culmine assoluto di un conduttore di X Factor che partecipa a un altro X Factor come cantante. È certamente molto ambizioso, come progetto, certamente molto originale, nella sua straordinaria banalità: perché chi non si chiede ogni giorno che cosa sia la felicità? E soprattutto chi non cerca risposte da amici, conoscenti saggi, guide spirituali, psicoanalisti e perfino social media o motori di ricerca?
Sulle questioni esistenziali, quelle che toccano il senso della vita, non esistono domande semplici, esistono soltanto domande di cui abbiamo trovato, o comunque conosciamo, la risposta. Ora, provate a dare una risposta a questa semplice domanda: come si diventa felici? Ecco, da questo interrogativo familiare, posto da una figlia, parte il viaggio di Alessandro Cattelan su Netflix, una trasmissione in più puntate e più interviste e più trovate spettacolari, fino al culmine assoluto di un conduttore di X Factor che partecipa a un altro X Factor come cantante. È certamente molto ambizioso, come progetto, certamente molto originale, nella sua straordinaria banalità: perché chi non si chiede ogni giorno che cosa sia la felicità? E soprattutto chi non cerca risposte da amici, conoscenti saggi, guide spirituali, psicoanalisti e perfino social media o motori di ricerca? Quella sottilissima, pessima sensazione che la guerra iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina da noi sia diventata, in meno di un mese, poco più di un argomento da talk show non mi abbandona. Eppure spero tanto sia una sensazione sbagliata. Il problema di fondo è che da tempo la politica nazionale è diventata una sorta di nuova telenovela costante e permanente che consente alle televisioni di creare personaggi e serie di trasmissioni a costi contenuti, con protagonisti predefiniti e giochi di ruoli scontati, ma pur sempre efficaci in termini di audience. Questa tendenza si abbevera del tema del momento, che in tempi ordinari è la polemica del giorno, magari soppesata bene grazie ai flussi di “mi piace” o “non mi piace” sui social media. In tempi straordinari, invece, questo fenomeno è accentuato dalla presenza di una trama prestabilita molto forte e capace di monopolizzare l’attenzione degli spettatori e dunque gli sforzi di autori e conduttori televisivi. Così è accaduto prima con il Covid e i virologi e i politici e i commentatori e poi adesso con la guerra e i generali e di nuovo i politici e gli analisti militari e di politica estera. Una delle concause di questo possibile slittamento dall’informazione all’infotainment, come si suole chiamare quel mix di informazione e di intrattenimento che riempie i nostri palinsesti, è la scarsa distinzione tra i notiziari, le trasmissioni di approfondimento e i talk show più o meno leggeri. Il tutto “aggravato” dalla difficoltà di affermazione presso il nostro pubblico delle reti all news, nonostante i pregevoli sforzi di approfondimento di SkyTg24, di copertura completa di RaiNews e di sensibilità ai temi politico-economici del Tgcom24.
Quella sottilissima, pessima sensazione che la guerra iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina da noi sia diventata, in meno di un mese, poco più di un argomento da talk show non mi abbandona. Eppure spero tanto sia una sensazione sbagliata. Il problema di fondo è che da tempo la politica nazionale è diventata una sorta di nuova telenovela costante e permanente che consente alle televisioni di creare personaggi e serie di trasmissioni a costi contenuti, con protagonisti predefiniti e giochi di ruoli scontati, ma pur sempre efficaci in termini di audience. Questa tendenza si abbevera del tema del momento, che in tempi ordinari è la polemica del giorno, magari soppesata bene grazie ai flussi di “mi piace” o “non mi piace” sui social media. In tempi straordinari, invece, questo fenomeno è accentuato dalla presenza di una trama prestabilita molto forte e capace di monopolizzare l’attenzione degli spettatori e dunque gli sforzi di autori e conduttori televisivi. Così è accaduto prima con il Covid e i virologi e i politici e i commentatori e poi adesso con la guerra e i generali e di nuovo i politici e gli analisti militari e di politica estera. Una delle concause di questo possibile slittamento dall’informazione all’infotainment, come si suole chiamare quel mix di informazione e di intrattenimento che riempie i nostri palinsesti, è la scarsa distinzione tra i notiziari, le trasmissioni di approfondimento e i talk show più o meno leggeri. Il tutto “aggravato” dalla difficoltà di affermazione presso il nostro pubblico delle reti all news, nonostante i pregevoli sforzi di approfondimento di SkyTg24, di copertura completa di RaiNews e di sensibilità ai temi politico-economici del Tgcom24.







